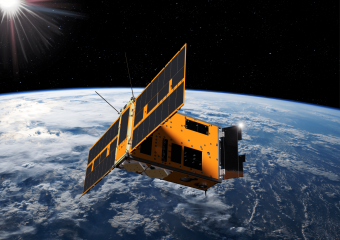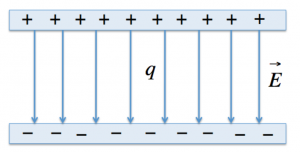Fotografia di Gaspare Nuccio.
«Oggi, dopo mille stragi, dopo Falcone e Borsellino, ogni spazio parrebbe chiudersi, non dico all’idillio, ma alla fiducia più esangue. E tuttavia…finché in una biblioteca mani febbrili sfoglieranno un libro per impararvi a credere in una Sicilia, in un’Italia, in un mondo più umani, varrà la pena di combattere ancora, di sperare ancora. Rinunziando una volta per tutte a issare sul punto più alto della barricata uno straccio di bandiera bianca», scrisse Gesualdo Bufalino nella nota Poscritto 1992 contenuta nell’antologia Cento Sicilie.
Alla vigilia degli anniversari dei due eventi, la strage di Capaci e quella di via D’Amelio, che hanno segnato la contemporaneità della storia repubblicana, il giornalista e scrittore palermitano Piero Melati pone con il libro La notte della civetta (Zolfo editore, 288 pagine, 18 euro) domande taciute, che ci fanno evadere dalla riserva indiana nella quale è costretto un pezzo gigante della biografia nazionale. La storia della Sicilia è quella d’Italia. Melati ci libera dalla retorica degli eroi, per leggere le pagine chiare e tentare di decifrare quelle ancora oscure.
Non si tratta delle memorie di un reduce che, da giornalista de L’Ora e poi a La Repubblica, ha vissuto in prima linea lo stravolgimento democratico del terrorismo di stampo politico mafioso a Palermo. Melati prende atto delle contraddizioni e delle divisioni, come quelle che hanno separato Sciascia e Falcone dallo stesso fronte, per scavare nelle memorie rimosse. La notte della civetta, al fine di non issare la bandiera bianca di Bufalino, è la promessa di non rinunciare alla complessità della storia.
Ricordando la vita di Rita Atria, evochi una domanda attualissima: cos’è questa “cosa” chiamata mafia che riesce a essere più forte del rapporto di una madre con la figlia?
«È difficile rispondere. Dopo l’assassinio del padre e del fratello, immersi nella realtà mafiosa di Partanna, Rita scelse di testimoniare e raccontare ciò che sapeva. Paolo Borsellino accolse le sue dichiarazioni preziose, la protesse e costruirono un legame molto forte, mentre la madre la ripudiò. Seppellita nel cimitero di Partanna, la madre andò parecchi mesi dopo a trovarla con un martello, per spaccare la sua foto sulla lapide. Il testamento di una ragazzina, suicidatasi dopo la morte del giudice, apre ancora scenari nuovi, e non certo per una volta esclusivamente giudiziari, a cui non siamo più abituati».
Quali scenari?
«Ormai guardiamo il fenomeno mafioso solo dal punto di vista investigativo. Si è perso lo sguardo trasversale e d’insieme, che si posa e torna alla radice delle esistenze».
Lei che cosa era riuscita a vedere e capire?
«Rita teneva un diario. L’ultima notazione è questa: “Roma, dopo il 19 luglio 1992, strage di via D’Amelio. Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l’unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà, e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci”. La mafia non è un fenomeno naturale siciliano, ma attecchisce per ragioni precise. Quello chi manca ancora è affrontare il contesto e il condizionamento mafioso in ogni vita».
Falcone, Borsellino, Cassarà, Montana, Chinnici e cento altri sono stati uccisi poiché erano insostituibili?
«Lo spiega anche Joseph Roth in un suo romanzo (La marcia di Radetzky) che parlava dell’Impero Asburgico. Qualsiasi istituzione può impiegare anni a sostituire un ottimo funzionario. Hanno assassinato Ninni Cassarà, intelligenza e anima della Squadra mobile di Palermo, e non è stato trovato nessun altro di quello spessore. Ucciderli equivaleva a incrinare la macchina dello Stato, a ritardare le indagini per anni».
Qual era l’eccezione di Cassarà?
«Apparteneva a un’antimafia utopistica, che è durata poco e ha portato risultati concreti come le condanne del Maxiprocesso. Riteneva che la sconfitta, o almeno il ridimensionamento, di Cosa nostra tramite la cattura dei latitanti avrebbe potuto cambiare in meglio la società siciliana. Si trattava di sconfiggere il cancro che lacerava la società dal suo interno. La rivoluzione o palingenesi si è fermata sulla soglia delle loro idee. L’esito positivo del Maxiprocesso non si è tradotto nel cambiamento radicale immaginato. Dopo il 1992 le mafie, sempre più finanziarie, sono tornate nella fase di immersione e si fatica a riconoscerle. Non abbiamo guardato in profondità a che cosa ci è successo in quegli anni».
Il corpo di Palermo come ha sopportato tali emorragie?
«Quale impasto sociale e umano ha potuto tollerare che tre Kalashnikov sparassero a Cassarà sulle scale di casa, mentre la moglie con la bambina piccola urlava, bussava alle porte per salvarsi e nessuno le aprì. Quella dell’autobomba di Chinnici che città è? Leggevamo nei giornali “Palermo come Beirut” sul terrazzino della casa di famiglia, mangiando il gelo di mellone. Poi ti abitui a tutto, le dittature sono così. La fine è solo l’annientamento, perché arriviamo a tollerare tutto. Vedo una relazione con la parola totalitarismo e persino con il regime concentrazionario».
Il terrorismo di stampo politico-mafioso di Cosa nostra ha cambiato il senso della morte?
«I siciliani hanno per una serie di ragioni una relazione più diretta e sanno guardare la morte. Cosa nostra è riuscita a distorcere questa natura. Distribuendola dappertutto, ha reso la morte il suo volto pubblico. Doveva ostentare il potere di mostrare il morto. Dopo la scomparsa di De Mauro, dal 1979 in poi gli omicidi eccellenti hanno lasciato una traccia in ogni strada. A cominciare da quello di Mario Francese che doveva essere un segnale per tutti i giornalisti. Era il rito per mostrare la potenza. Si sono impossessati della morte e della possibilità di darla».
Per anni Falcone parlò pochissimo, poi l’accusarono di protagonismo. Iniziò a morire, quando lo fece?
«Dai magistrati del pool antimafia non avevamo mai notizie. Un costume che si è perso negli anni successivi. Nella prima parte della carriera Falcone aveva un rapporto difficile con i giornalisti, perché lo irritava l’approssimazione con cui venivano affrontate certe vicende. Dal 1979 almeno fino al 1983 parlò davvero poco. Poi si rese conto che aveva bisogno di una buona comunicazione, affinché il suo lavoro e del pool antimafia venisse raccontato nelle giuste dimensioni. Iniziò a rilasciare interviste con una selezione accurata degli interlocutori e mantenendo la giusta distanza. La necessità emerse, quando capì che la battaglia giudiziaria stava raggiungendo l’apice. Tentò di scuotere l’albero e di piantare semi fecondi. È il periodo in cui venne fischiato persino dai suoi colleghi come nel tribunale di Milano, che oggi espone la foto di Falcone e Borsellino».
Che cosa abbinava Falcone alla capacità di seguire i percorsi e le relazioni dei soldi?
«Carla Del Ponte rimase sorpresa che Falcone, il quale in passato aveva fatto anche il bancario, fosse l’unico a saper leggere i documenti delle banche svizzere. La sua grande intuizione fu di seguire le tracce dei soldi. Sapeva che la pista era quella e l’ha contestualizzata non in astratto ma nella società siciliana, dentro l’organizzazione criminale. Lui, nato alla Kalsa, qualcosa di loro la capiva. Ha associato alla capacità di tracciare i soldi quella di conoscere la natura degli uomini. Era istintivo con un’incredibile metodicità nel lavoro».
Qual è l’aspetto più interessante del rapporto con Buscetta?
«Riuscirono a capirsi. Quest’ultimo pose dei limiti e Falcone li accettò. Il collaboratore di giustizia intendeva vendicarsi dello sterminio dei propri famigliari e nel raccontare era disposto a spingersi fino a un certo punto. In cambio Buscetta garantì una lettura dall’interno del fenomeno mafioso, ma non è stato il primo».
Più dei secoli di carcere inflitti all’ala militare di Cosa nostra, lo scacco matto del Maxiprocesso fu il riconoscimento con almeno trent’anni di ritardo dell’esistenza di questa organizzazione mafiosa.
«Non c’è dubbio. Questo è stato il passaggio cruciale, che ha portato allo stesso Maxiprocesso: lo stabilire che Cosa nostra esisteva e non era una semplice associazione a delinquere. Dopo tanti caduti che avevano tentato di scollinare questa altura si arrivò in vetta. Un passaggio delicato e così fondamentale che i successivi sono apparsi sempre in tono minore, se non confusi, come il concorso esterno in associazione mafiosa con letture difformi da parte della Cassazione».
Senza ricostruire la linea continua da Terranova a Chinnici non si può comprendere questa svolta. Che cosa rappresentò Rocco Chinnici per Palermo?
«Falcone guardava la mafia verso l’alto: le banche svizzere, i riciclaggi, gli equilibri interni alle “famiglie”, i legami tra boss e grande potere. Seguiva gli assegni. Chinnici era ossessionato dalla strada. Non gli sfuggiva mai il collegamento tra quei livelli più sofisticati studiati da Falcone e quel che si consumava nel giardino di casa della città. Ma proprio per questo a colpirlo non era tanto l’albero avvelenato, ma i suoi frutti mortali: le fontanelle, le siringhe, i ragazzi che si bucavano».
Chinnici comprese pienamente la portata del capovolgimento sociale della narcoeconomia.
«Aveva chiara la misura dell’aumento geometrico di quella peste. Lo ascoltavano con insofferenza, lo accusavano quasi di non parlare d’altro. È stato l’unico a dire con coraggio che le vittime di overdose erano vittime di mafia. Ha assistito e reagito al massacro di una generazione, quella delle occupazioni universitarie del ’77. Questo dolore riguarda tutti ma non lo codifichiamo in nessun libro di storia. È stato un effetto del trasferimento dei laboratori di Marsiglia, che furono nulla rispetto alle raffinerie di droga in Sicilia».
Qual è stato il riflesso delle raffinerie e dei soldi del traffico di droga sull’urbanistica palermitana?
«Come in America tramite l’economia diffusa dello spaccio si distruggeva l’equilibrio sociale di un quartiere per la costruzione di nuovi e lo spostamento delle persone. Nacquero quartieri finti. I soldi della droga fecero costruire i palazzi e lo sapevano tutti. Palermo è diventata essa stessa una città finta e del tutto sradicata».
Che cosa ricordi del nove maggio 1978?
«Quando Sciascia parlava di incidenze e coincidenze aggiungeva: “Alcune volte mi sembrano le uniche che possono spiegare i fatti”. Certamente quella giornata è stata un cambiamento epocale. Al vertice della piramide morì Aldo Moro e con lui crolla il ponte che collegava l’anima cattolica e quella comunista del Paese. Alla base, a Cinisi, assassinarono l’unico ragazzo della sua generazione che in dieci anni, dal 1967 al 1977, non aveva dimenticato la questione mafiosa. Dopo l’omicidio Scaglione e la scomparsa di De Mauro, il movimento studentesco siciliano ignorava quasi l’esistenza della mafia. Non volava una mosca».
Impastato, un mafioso, il padre, lo aveva in casa.
«Sì e un altro di caratura mondiale, Tano Badalamenti, a cento passi della propria abitazione. Peppino aveva assistito alla costruzione di un aeroporto in uno dei luoghi considerati più pericolosi dai piloti. Badalamenti era il proprietario dei terreni, mentre Liggio, considerato ancora il boss emergente, si poteva limitare ai lavori di sbancamento della terra. Impastato sapeva benissimo chi comandava. Mentre la sua generazione, che provava la sensazione interiore della fine del mondo, soggiaceva alla merce venduta dal prototipo moderno dei narcos, lui dalla radio indicava e percorreva la strada opposta all’invasione dell’eroina».
Qual è l’eredità di Impastato a dispetto dei santini?
«La beatificazione è una maledizione, perché rende queste figure estranee a noi. Bisogna pensare al ragazzo normale che in quegli anni aveva in mano una radio libera per dire ciò che non leggevamo nei giornali e che le persone temevano di pronunciare anche nel chiuso delle case. Lo considero in relazione alla radio. Esisteva la necessità di parlare un altro linguaggio. Lui con ironia e coraggio ne costruì uno. E in Sicilia la costruzione di una lingua nuova doveva passare dal rendere pubblica la lotta alla mafia».
In che modo dialogano i libri di Sciascia Il giorno della civetta e L’affaire Moro?
«Il giorno della civetta scoperchiò per la prima volta tutto. Lo scrittore, che aveva già dato contro la mafia, sfidò l’Italia intera e il patto di unità nazionale contro il terrorismo scrivendo L’affaire Moro, e che riceve e parla con i suoi concittadini con altrettanto disincantato distacco e senza obbligo all’empatia, alla maniera dell’amato Stendhal, con la freddezza di un entomologo».
L’unica monografia sul giudice Cesare Terranova vide il contributo decisivo di Leonardo Sciascia. Era vicino a Chinnici. Come si può spiegare la distanza con Falcone?
«Tutti noi siciliani viviamo all’ombra di questo comune, inconciliabile magistero, quello del giudice sacrificatosi nella lotta contro la mafia, e quello dello scrittore che – tra gli altri suoi alti meriti – per primo la denunciò, parlandone al mondo. Sciascia non giustificava la geometrica e razionale freddezza di Falcone, che nasceva dal fuoco che uccise Terranova e Chinnici. Sciascia non capì che i giudici stessero cambiando attraverso quel fuoco e la prossimità sempre più schiacciante di Cosa nostra. Non esisteva più la possibilità di guardarla con il distacco con il quale aveva potuto scrivere Il giorno della civetta. L’unico romanzo sulla materia che resta efficace».
È ancora difficile riconoscere la reciproca inconciliabilità?
«Dovremmo ammettere l’esistenza di un paradosso che assomiglia a una ferita aperta: la differenza tra lo Sciascia che scrive Il giorno della civetta e quello dell’articolo I professionisti dell’antimafia. È la stessa persona, ma offre due visioni diverse rispetto all’amicizia con Terranova. Dobbiamo accettare la sua piena insondabilità. L’articolo era profetico in alcuni sensi, ma come ricordò Borsellino quel giorno Falcone iniziò a morire. Dopo il caso Tortora, Sciascia diffidava dei Maxiprocessi e delle procure dopo il suicidio del segretario regionale della Dc Nicoletti».
Bufalino colse lo sgomento di questa freddezza?
«Sì, e stando più a distanza dalla materia rispetto a Sciascia, vide la linea di continuità da Terranova a Falcone. La storia mancata tra Falcone e Sciascia è un frutto di Sicilia: una terra che fa i suoi figli migliori e poi li mette contro».
Paolo Borsellino raccolse anche questo frutto amaro. In che cosa consisteva la sua umanità?
«Disse il consigliere Antonino Caponnetto: “Non ho mai conosciuto un uomo più umano e giusto di Paolo e non lo conoscerò sicuramente mai”. Paolo invece sussurrava: “Sarò sempre il secondo di Giovanni”. Dal punto di vista dell’umanità e del coraggio, Borsellino giganteggia. Non so quali altri esempi si possano trovare. Una persona che va lucidamente alla morte per oltre cinquanta giorni. Visse la fine con profondo tormento e cupezza, ma insieme ad atti pubblici decisivi continuò a dare messaggi di amore ai figli, alle persone. Come disse il filosofo siciliano Gorgia da Lentini, a proposito degli eroi della guerra del Peloponneso del suo tempo, erano uomini concreti che hanno accettato la situazione in cui si trovarono e seppero agire come le circostanze richiedevano. Per questo non ne deve essere perduta la memoria. Riesco ad associare questa esperienza che pone interrogativi etici, morali, umani a quella dei campi di concentramento».
Che effetto ti fa la dicitura “Borsellino quater”?
«Per pigrizia guardiamo le due stragi nello stesso modo, poiché ravvicinate nel tempo. In realtà quella di Capaci è stata compiuta per la stabilizzare la situazione con l’elezione del Presidente della Repubblica. La strage di via D’Amelio al contrario per destabilizzare. Dunque questa seconda risulta a livello processuale ancora più ingarbugliata con depistaggi ormai acclarati per non far emergere ciò che è stato».
Qual era il tuo patto con il capo del pool Antonino Caponnetto?
«Gli promisi di non disturbarlo mai, perché era spesso assalito da grupponi di inviati con domande talvolta improbabili. Però gli dissi: se le busso, la prego, mi risponda, perché si tratterà di un’emergenza. Al Palazzo di giustizia di Palermo, dove andavo quotidianamente, mi ricevette per confermare la voce dell’arresto di Michele Greco, il “papa” della mafia, il capo della Commissione: “Giovanni è andato in caserma per il riconoscimento”. Caponnetto era ieratico, gentile. Negli anni del Pool ha fatto da chioccia e parafulmine. Aveva sentito la “corda pazza”, per usare l’espressione di Sciascia. Era siciliano ed ebbe il richiamo della terra madre».
Nel 1987 dopo la conclusione del Maxiprocesso hai lasciato Palermo. Quanto ha pesato il bagaglio di quella guerra?
«Nei primi anni vissuti lontano dalla Sicilia mi ha continuato a inseguire, poi me ne sono liberato per infine tornare ad aprirlo con più distacco. In gran parte è un nodo che non si risolverà mai. Più in generale il modo errato di fare memoria lascia incagliate le questioni storiche».
Qual è il tuo ricordo del giornale L’Ora?
«Gianni Lo Monaco, il vecchio cronista di giudiziaria, che arrivava il pomeriggio con il cane e ci raccontava le storie, inquadrava i fatti e il loro contesto storico. Ti dava sempre una pista da seguire. Ci spiegava come non diventare dei passacarte. Eravamo poveri, sporchi, ma il giornale mi ha dato tutto».
Alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci, arriva dalla Sicilia la notizia dell’arresto del Commissario Covid Antonio Candela. Che cosa indica?
«C’è una questione urgente e attuale. Il “capo condominio” della sanità siciliana, accusato per tangenti con il suo sodale agrigentino, peraltro membro della commissione siciliana antimafia, era sotto scorta, come tanti prima di lui, per minacce dovute al suo presunto impegno in favore della legalità. C’è un marcio evidente e ricorrente, annidato dentro l’apparato retorico ufficiale inaugurato nel dopo stragi del ‘92, che viene da tempo utilizzato non solo come scorciatoia per carriere da abili professionisti, ma anche come nuovo sistema di potere e copertura della novella corruzione. Sanità ma anche discariche, scioglimento sospetto di consigli comunali ma anche gestione dei beni sequestrati alla mafia, e avanti così».
L'articolo La notte della civetta. Intervista a Piero Melati proviene da minima&moralia.